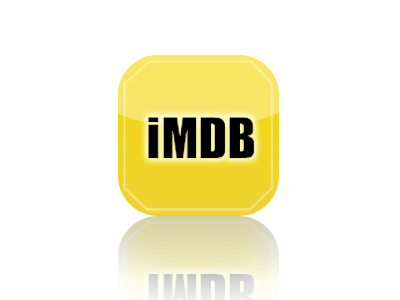Il gran dispitto che c’è
(Cristina Annino)
Il libro di Ugo Magnanti Il nome che ti manca, edito da peQuod 2019, si compone di sette sezioni.
Già il titolo è emblematico di un procedere narrativo ondulatorio che l’autore manterrà sempre, sia che si tratti di dittologie sinonimiche o di ossimori. Ne deriva così un andamento poetico curvilineo, il quale tradotto in termini visuali dà l’idea di un uomo che cammina con una spalla curva, come fanno i marinai, oscillando tra il dire e il suo contrario, e già contenendo in sé quell’immagine di mare molto presente ovunque in queste pagine. L’acqua stessa trova sostanza visiva in tali emistichi o autocensure, e potremmo continuare all’infinito definendo tutto ciò che egli deliberatamente non definisce, proprio perché tale andamento genera immagini fisiche extratestuali. Potrebbe essere un processo inverso della PoesiaVisiva. L’immagine del muro, altro esempio, quella grande striscia di dipinto murale in cui si incastra perpendicolarmente il poemetto più lungo, per poi farci tornare all’orizzontalità delle ultime sezioni. Ed è esattamente tale parte (L’Edificio Fermo) che traghetterà il senso dalla prima alla seconda ala del racconto poetico.
Perché la visione di un murale? Anche e soprattutto perché Magnanti è senza dubbio un poeta metropolitano, almeno quanto civico è il senso della propria scrittura, della sua personale organizzazione del bello, cioè più profondamente del pensiero. La sua proliferazione di immagini rimbalza quindi su noi idee di visioni urbane.
Inoltre Magnanti è un poeta complesso che mi piace definire folto fino all’ebollizione.
Ma procediamo con ordine.
La prima parte ha per titolo Poesie del santo che non sei; inizia così il disegno murario. Qui il poeta non parla in prima persona: ci rappresenta un lui al bar, il suo numero di scarpe, l’orologio giallo, quel lui che pianta una palma in giardino, transita nell’orto, passa da una stanza all’altra della casa, e così via… Ecco, ogni poesia sembra la rappresentazione di come sia mediocre certa “realtà”, o certa quotidianitàpriva di preoccupazioni che vadano al di là di ciò che viene compiuto al momento, insomma un disegno del comportamento umano attraverso individui occasionali, verso i quali lui senta un inconscio senso di “colpa”. Colpa per esserne contemporaneo, oppure in qualche modo contaminato, se infatti leggiamo l’esergo, si trova l’ammissione “i sensi mi spinsero a trascurare la purezza […] mi davo da fare insieme agli alti, tutti venuti con me da un ventre sanguinante”, oppure per ammettere che ogni azione, in fondo, è solo una simulazione di gesti reali.
Siamo già dentro al linguaggio forte di questo autore, linguaggio alquanto brusco, a tratti persino cinico, come si può leggere nella chiusura della poesia a pag. 18: “empio! che si infettassero altri cento”.
Nel Battito Argentino, il poeta presenta la propria fisicità, dalla rappresentazione generale dell’uomo passa al proprio auto ritratto. Appare molto giovane e che abbia una complicità col se stesso visto, poniamo, allo specchio. Si compiace di avere l’“epidermide del corvo”, cammina e si agita e vive spavaldamente come dentro una sonorità che io definisco ispanica, rappresentativa, recitata di petto. Ora più niente sta sullo sfondo, quest’ironia è toracica. Non ci sono figure femminili protagoniste, come quasi mai ne troveremo in seguito, (nel senso appunto di presenze autonome) qui c’è solo la lanugine di un atto sessuale generico, generazionale più che sentimentale. In questa sezione abita il suo io “pallido o negro/islamita o cristiano/compare delinquente/oppure onesto”.
Escludendo l’Edificio Fermo, questa, tra le raccolte di poesie brevi, è quella che preferisco, il linguaggio è pienamente suo, le metafore forti, il dispitto con cui guarda la realtà del mondo, da ora non lo abbandonerà più. Qui si potrebbe cautamente pensare a una poesia ideologica, ma in effetti l’autore non prenderà mai una posizione decisa rimanendo nella sfera di quel dispitto ripeto, di quella insofferenza- espressa più o meno chiaramente- verso l’essere umano e che diventerà più incisiva nel poemetto lungo.
Questo costituisce la terza parte, la più importante, a mio giudizio, del libro; giacché Magnanti è più poeta quando più narra, e ritengo quindi che questa sezione illumini tutto il resto, abbia intendo, l’importanza che il cuore ha rispetto ad altri organi del corpo. Qui parla un Io con cento teste, addirittura sperimenta arie multiple, inventa toni diversi di racconto, si allarga e si restringe, con malumore ormai cronico, cinismo, compassione, selvatichezza; confida sensazioni che poi contraddice, sempre in bilico su emozionalità differenti che unisce, scandendo con ossessione ossimori tenuti apparentemente sotto un velo d’acqua. Con disincanto e a volte lieve crudeltà.
Si potrebbe scrivere un saggio, indagando come un artista possa costruire su tali slogature, o emozioni, anche se spesso non rese facilmente comprensibili, un’odissea di immagini potenti.
Nella sua scrittura raramente si trova passione per il genere umano.
Tale dato emerge alla terza o quarta lettura del testo, allorché se ne possono sezionare i vari centri emotivi e di contenuto: poesia, natura, conoscenza, animali, vita, ecc.
Ritengo questo un dato molto importante della sua poesia: la dichiarazione di sfiducia verso una collettività che non ha più radici nella propria cultura, la paura di perdere egli stesso il senso della storia. La paura soprattutto che non si possa più costruire sull’Uomo.
Proseguendo la lettura di questa sezione, troviamo il verso “la cosa che contò di più fu vivere […] subito seguito dalla contraddizione, “Con ogni cellula sicura della sua orgogliosa statica”. Dal quadro si è quindi passati al soggetto stesso: ma i verbi, generano un’azione alquanto “riflessa”, giacché il motore primario è rappresentato dal ricordo, oppure dall’invettiva: “la voglia/ svergognata di stare ancora/ al mondo”, oppure “finisca pure l’estate […] finiscano persino le parole, finisca la poesia, che importa […] non avrò poesie da stringere” (66), di seguito “Non c’è un altro modo/ per chiedere un passato/ che possa appartenerti”. Si può osservare inoltre che le uscite all’esterno del metaforico edificio, a volte sembrano spostamenti da fermo, come succede nei sogni o nel desiderio: “questo in ogni/ caso sono io, /su un marciapiede, / e quello è un thermos/ sotto il sole alto […]”. A p. 58 batte un vitalismo spezzato a metà lirica, quindi, p. 60 “se ho sbagliato qualche/ verso, per caso o per abuso […] perché tutto si muoveva /dentro l’edificio fermo”.
Dunque agìti, tentativi, ricordi, che potremmo chiamarli anche oblio quale coscienza dell’io protagonista, per il fatto che sempre manca una volontà attiva la quale sostituisca il ricordo con qualcosa di attuale, o che sia diretta contro qualcos’altro.
Nessun dinamismo tradizionalmente inteso, insomma, come dicevo sopra, a dominare è quasi un’omissione di chiarimento, o un oblio quale sopravvivenza al disincanto del presente.
Concluderemo allora che ricordo e oblio sono sinonimi, due facce cioè della stessa sostanza temporale quindi non contrarie tra loro. Non è detto infatti che l’oblio cancelli; io penso che l’oblio sia un protettore di ricordi, un contenitore di essenze esistenziali. Non è dimenticanza o tanto meno cancellazione, bensì esso memorizza a sua insaputa valori radicati nel profondo dell’uomo. (Ed è, aggiungo, una componente molto funzionale, anche al procedimento creativo).
Concluderemo soprattutto: che questa assenza di dinamismo, intesa come volontà di affermare il proprio pensiero, la riteniamo comunque una vistosa, importante risposta all’epoca nella quale il poeta si trova dispettosamente ad esistere. “Abbiamo scritto un’epica […] ma già assaporandone la triste esumazione”, si legge a p. 61. Come se l’attuale conseguenza storica fosse di restare fermi nell’attesa di un inesorabile declino fisico e spirituale, senza poter più agire, appunto, dentro la delusione di un pensiero compresso tra l’irrealtà di tante filosofie sociali storicamente vissute da una generazione o più generazioni, fino alla società aperta vagheggiata da Popper, dominata da programmi e diplomazia.
Torniamo al presente, alla poesia a p. 15, alla contrapposizione cioè tra scimmia e rosa.
Allora l’irrisione del poeta, la sua negazione, il disdegno, e le antinomie, costituiscono le sue risposte passive, sono la propria opposizione personale, giacché sempre confronta il suo sé di adesso con quello che culturalmente è stato. Del resto non è sempre vero che la vitalità, o lo spostamento e persino le azioni anche convulse, diano movimento a ogni spirito. O uguale senso di libertà all’animo di un uomo. A volte questi spostamenti sono copie di copie che si rinviano l’una all’altra in un processo infinito, diventando alla fine simulacri. Il platonico Magnanti non vuole la ripetizione in quanto essa è copia dell’idea, quindi essa simula, e per questo il poeta si cala nella dimensione dell’oblio che appunto non cancellando, può essere un modo di rivivere, almeno dentro di sé, l’idea originale, cioè l’avvenimento autentico.
Quale controcanto- Magnanti mostra una decisa dolcezza nei confronti della natura vegetale e animale, nature consolatorie, genuine perché non ripetitive, e mai degradate. Gli animali soprattutto, col dono appunto della continuità caratteriale e morale di cui è priva la natura umana, dispensano persino oblio, nei due sensi attribuibili a tale sostantivo. Per la prima volta a p. 41 compare la speranza, prolungata poi lungo tutta la vertiginosa pagina 42 che inizia: “tra quelli che sperano/ ci sono anch’io”.
La sezione termina con l’alleggerimento dei versi, p. 76: “spudorato e già pronto a ritornare vivo […] il tuo desiderio non è fatto per morire”.
Nelle sezioni seguenti incontriamo un Magnanti “tra la gente”, come se per un attimo si fosse spaccata la superficie del mare. Poesie brevi, addirittura distici nella parte VI che si intitola appunto Canti distici; l’agitazione del poemetto centrale si snellisce in uno sguardo stretto su quel che vede e niente gli appare bello: il moscone, se stesso, il prato, la luce del giorno falso, l’ovvia scala in attesa, sono versi pungenti rivolti ancora una volta, anche se più lievemente o saggiamente, a una sgradita umanità; “ho dovuto aspettare che un tale con la bocca spregevole prima ne dicesse il possibile male per comporre poesie con la rima”,scrive a p. 117. A p. 110 era spuntata l’idea di un sorriso triste, dove parla del piccione schiacciato da una biemmevù, e nella poesia seguente ritorna un’altra macchina guidata stancamente, che ripropone l’immagine della scimmia sovrapposta al guidatore peloso, anzi la scimmia è diventata, senza alcuna progressione di genere, il guidatore stesso dell’auto. Pensabile è un larvato darwinismo senza però evoluzione.
Nelle parti IV, Al nudo specchio e la parte V, 20 Risacche, si rivela meno l’ossessione di un io multiforme e presentato direttamente, dove la presenza del mare da metaforica diventa reale. Il mare sembra addirittura dentro di lui e genera sesso “ventre contro sabbia, negando l’evidenza della copula” e anche il “vento in casa penetrò dal mare”, verso dove il sostantivo vero è il mare, non il vento. Onde, conchiglie, scogli, barche, il mare è dappertutto anche non nominandolo direttamente, e il mare comprende tutti mari: marocchino, siculo sardo; insomma la geografia si dilata, l’edificio ha definitivamente rotto i suoi muri. Sono composizioni di notevole abilità stilistica, più simili all’acquarello che al murale dipinto con la vernice, ma ugualmente incisivi, anche se si è persa la rabbia o quel disincanto che emotivamente intrigano, tenendosi più vicino l’autore.
Il libro termina con Barlumi di un’America intuita da un’Italia e per poco, a tratti o per niente, ma almeno un po’ mascherata o di lato, la sua amarezza, acrimonia, viene come tradotta fisicamente. L’America non è lontana né vicina, ma c’è (ironia e contrarietà che emergono nei 4 righi di prosa a p. 121) “patrie, le più belle, torbide miscele [.] per essere per sempre una bestiola disonesta”.
Entra una realtà più moderna, coi campi da gioco, grattaceli, studenti. Il ritmo poetico è più disteso, non ricompaiono gli ossimori, le dittologie sinonimiche, “il clima è scioccamente estivo”, ‘certo’, “una giovane sorella va in giro per la questua”, si “stenta ancora a credere alla reclame fondata su una faccia”. Sono sintomi, questi, di una sistemazione a metà dell’uomo al posto dell’uomo che Magnanti sognava: si è insomma negli sciocchi paesi lontani e vicini perché inquinati. Perfetti magari! Come lo sono i bisonti, e splendidi quanto il Messico.
Le scarpe con il numero di sempre,
ovvio!; l’orologio invece comprato
un anno fa, giallo come un insetto.
E il vecchio muro verso cui sei sceso,
per metà uomo e per metà creatura,
a volte confessato dalla ruggine,
a volte dalla parodia: la ruggine…
fu anche più aspra della parodia.
Tengo perlopiù
l’epidermide del corvo
forse più ombrosa
o forse meno ombrosa
ma pure declino dall’est
e approdo qui con l’Albania
e sono cereo e dorato
così
sia io pallido o negro
islamita o cristiano
compare per delinquere
oppure onesto
così
io proferisca con bontà
e scatarri sul mattone
o sull’asfalto.
Viene l’erba di febbraio
ed è un piccolo supplizio,
perché scopri che riluce
ma non vuole dire nulla,
anche se sul prato passa
un vento lieve, e le voci
abbandonate dagli ultimi
palazzi cantano la voglia
svergognata di stare ancora
al mondo, con la vertigine
che un po’ stordisce
e gialla piange, ma poi grigia
in ogni fibra non rinuncia
al gusto di essere ammazzata.
Pregano le ore che avevi
disprezzato, e si lasciano
incantare dalla faccia che
riappare per vivere più
forte, più lenta, più vorace,
rivelata come lo sciogliersi
di resine fiorite dentro
una pineta, quando tutto
quello che potresti dire,
si ferma prima che la bocca
ammaliata possa dire.
Cinque esseri umani
che attraversano la
strada, un equipaggio
dalle braccia grasse
e rosse, che prova
a consistere in
qualche verità.
Nulla che non abbia
un nesso con le nuvole,
che non sia rappreso
come il giorno, nulla
che non sia cielo
disteso sulle fronti,
o che non abbia
smarrito l’occasione
di accadere in altri
modi: questo in
ogni caso sono io
su un marciapiede,
e quello è un thermos
sotto il sole alto, come
se non fosse aprile:
serve a mantenere
fresca l’acqua,
sfiorata da un ciclista.
Ecco, solo adesso è certo,
sono stati rari i giorni
e poche volte si è visto
qualche istante svelare
a sé stesso il suo splendore.
Siamo stati stupidi
a scivolare via così,
malgrado fosse inverno
e un funerale radioso
si snodasse in ogni linfa,
malgrado il sole dei
sobborghi sconosciuti
sembrasse un ornamento,
fin quando il sesso ebbe
le ossa per spezzarsi su
un tappeto, e l’idea di essere
cenere attraversò come
un mito luminoso il buio
di un atrio verso la calura.
Più che altro, più che
vivere, abbiamo scritto
un’epica, neppure
d’accordo con noi stessi,
ma già assaporandone
la triste esumazione.
Ugo Magnanti ha pubblicato diverse opere di poesia, tra le quali, più recentemente, Il nome che ti manca, peQuod, con due note di Carlo Bordini e Rino Caputo, 2019; il poemetto in ‘stanze’ L’edificio fermo, con prefazione di Antonio Veneziani e una nota di Cristina Annino, FusibiliaLibri, 2015; e la plaquette Ciclocentauri, con tavole di Gian Ruggero Manzoni, FusibiliaLibri, 2017. Fra le curatele Quanto non sta nel fiato, tutte le poesie della poetessa serba Duška Vrhovac, prefazione di Ennio Cavalli, FusibiliaLibri, 2015; Sogni diterre lontane, di Gabriele D’Annunzio, prefazione di Pietro Gibellini, Scoprirenettuno, 2010. Fra le tante presenze a manifestazioni di poesia, nel 2012 ha partecipato al 49° “Festival internazionale degli scrittori di Belgrado”. Ha ideato e diretto numerosi eventi letterari e ‘azioni poetiche’ in varie città italiane, con centinaia di presentazioni, incontri, rassegne, letture. Nel 2010 ha ideato e diretto “Nettuno Fiera di Poesia”: poeti, libri di poesia, piccoli editori nel Lazio. Lavora come insegnante di materie letterarie in un istituto superiore.