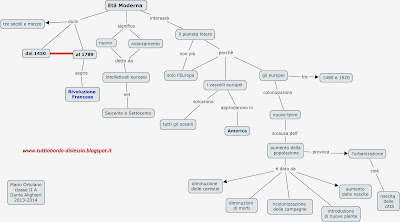Di che cosa tratti Ciclica(La Vita Felice, 2014), l’ultimo libro di Annamaria Ferramosca, me l’ha scritto direttamente lei in una mail: “il tema si identifica con la nostra richiesta di senso lungo ogni fase della vita e occasione del quotidiano, insomma come una continua vigilanza che acuisce il dolore di fronte al degrado globale, dell’umanità e della natura.”. Due sono quindi i temi entro cui si muove quest’opera: l’inevitabile “urto” del mondo sugli esseri, che è incontro / scontro, modo in cui si sta nell’aperto dell’esistenza, sempre segnato dal contatto; l’autodistruzione della civiltà o perlomeno il suo progressivo imbarbarimento, “gli infiniti modi [che essa ha] di sprofondare”.
Il libro si apre con la necessità di scegliere dentro la confusione di facebook, entro un mondo ipertecnologico che sfalsa le relazioni. Il contatto diventa così contagio malefico; l’occidente tutto, invero, contamina il mondo con il suo tramontare “senza ritorno di alba”, lo travolge. “L’insulto alla terra” è costante e, proprio per questo, noi dobbiamo ripensare il paradigma dello sviluppo, l’irrazionale equivalenza tra benessere e felicità. Dovremmo imparare dagli alberi, ci dice la Ferramosca, “mappe di salvezza / dispiegate nei rami”, testimoni di pienezza che ci invitano a curare frutto e radice e a tramandare il messaggio: “sii migliore del tuo tempo”. Perché ciascuno di noi è appunto relazione, per quanto assediata dal buio: “Il toccarci denso abbiamo / il vederci il pensare il nudo fare”. Ecco che l’urto può essere gentile, come recita la terza sezione del libro; “il tocco-random di una mano / che plasma e scompiglia” aveva scritto in Fioriture, quasi in principio di Ciclica, così che il contagio non infetta, ma salva, se risultato dell’incontro tra parola e cosa: “Con la lingua vorrei solo esultare / […] sulle cose far luce / anche feroce […] / o velarle le cose di compassione / coprirle scoprirle interrogarle / romperle corromperle / ammalarle infettandomi guarire”. Lei, biologa, sa quel che dice, conosce la natura uniforme della materia, l’esser fatti della medesima sostanza, in quel centinaio di elementi chimici organizzati nella tavola periodica.
L’altro collante è la memoria, l’infanzia che la memoria recupera anche attraverso la scrittura e qui messa in gioco soprattutto nella sezione “Urti gentili” dove la terra natale, il Salento, traspare con tutta la sua carica di nostalgia.
Coerentemente con i suoi libri precedenti (in particolare Curve di livello e Other Signs, Other Circles), la Ferramosca contrappone la linearità del pensiero platonico-cristiano alla circolarità della natura: Ciclica, come lei stessa mi scrive, “nel nome evocail destino cosmico che tutto accomuna”. Destino che tuttavia, pur non togliendo la paura della morte, la fa rientrare in un ordine superiore, “un oltre riconoscibile gentile / terra calda dai suoni attutiti”: un aldilà più pagano che cristiano, un “paradossale calmissimo caos”; un passare da uno stato all’altro dell’essere, come direbbe Severino.
Dalla sezione Techne
scelgo mi piace e condivido
soltanto se
la posa non è teatrale se intravedo
il capo rasato sotto la pioggia
la stanza fiammeggiare
allontanarsi il punto cieco
l’urto mi chiedi l’urto ma
sei virtuale un’ipotesi una
finestra sul vuoto poi non so
quanto davvero vuoi
farti plurale
dimmi se chiami per conoscermi o solo
per riconoscerti
chiami chiami dai tetti
da eccentriche lune chiami da
nuvole pure dal basso chiami
voce di fango che mi macchia il petto
segna la fronte pure
si fa lacrima cristallo che
taglia il respiro
stiamo come in un rogo a far segni attraverso le fiamme
malferme sagome stordite da mille nomi
la lingua disartícola e l’audio
sarebbe comprensibile soltanto se
intorno il rumore attutisse
se fossimo
puro pensiero silenziopietra
statue serene dal sorriso arcaico
ai piedi un cartiglio e
lampi negli occhi
trasporto in files
tutte quelle diapositive ormai pelle da macero
impallidite in pile
forme disperse disperate da deportare
in fili d’aria files
un laser ti trafigge inesorabile
ti copia-incolla eri
così smagrito avevi
occhi di pianto e sorridevi
la postura inchiodata dal clic non sapevi
di accecarmi
il tuo respiro per anni conservato
in raccoglitori di plastica
concluso
per quali occhi salvato il tuo calco?
per quale tempo del riepilogo? del senso?
chi svelerà il mistero di un sorriso etrusco?
tutto quel sole sulla pelle
e il cuore in ombra
per chi ancora resistere durare ancora
di dura fine
fine hard disk
dalla sezione Angelezze
alberi
non sappiamo di avere accanto mappe di salvezza
dispiegate nei rami
gli alberi sono bestie mitiche
invase dall’istinto fieri suggerimenti
restare accanto
non per generosità ma per pienezza
-- intorno l’aria splende in rito di purità --
la terra tenere salda
perché sia quiete ai vivi
gli alberi hanno strani sistemi di inscenare la vita
prima di descrivere la morte
s’innalzano
con quei loro nomi di messaggeri
le vie tracciate sulle nervature
lo sgolare dei frutti
sii migliore del tuo tempo dicono
devo
far correre quest’idea sulla tua fronte
devo
e tu su altra fronte ancora
e ancora prima
che precipiti il sole
remi per itaca
E se la trovi povera, Itaca non ti ha illuso.
Sei diventato così aperto e saggio,
che avrai capito cosa vuol dire Itaca.
K. Kavafis
K. Kavafis
sarmenti dalle viti
in duello con l’aria
uno strappo deciso li stacca -- dente bambino --
deve ac-cadere prima che il legno s’addensi
e animelle sulle biforcazioni
deboli getti anch’essi da allontanare
animule respinte
con rabbia lanciano la loro delusione in terra
strato dopo strato fino alla vigna-nadir
(all’altro orecchio del mondo
tutto sarà compreso)
in questo braccio di appiantica un laerte
versa linfa nei rami si avverte
lo scroscio sottile lontani i remi di ulisse
l’angoscia l’esilio (qui la tortora ancora
sul nido a ripetere)
la casa è vicina alla cava di selce
perché sia graffito sul muro
il presagio vignarinascita
e sia compreso il tempo
compresi anche noi con il nostro
tozzo di paneolio e il bicchiere d’ebbrezza
la vita così simile a questa
nebbia etilica chiara di voci
il cielo rossoacceso
e in petto un’onda larga
così trascurabile
il prezzo della pace
dalla sezione Urti gentili
sotto la nuova luna
è già notte artica sotto la nuova luna
luna che bruca interroga
quali parole restano per quale
sovrappiù di voce?
inflessibile lampada scandaglia
il fondo della retina nella rete s’impiglia
eco indistinta che martella voci
quale verginità di suono a spaccare il fondale?
sulla banchisa alla deriva l’orso
dondola il capo con moto autistico
nell’impaziente attesa della fine
nessuno accorre
al gridoghiaccio indurito in gola
all’ultima domanda nessuno
dalle città febbrili dai multipiani ciechi
dagli abitacoli che schizzano sulle autostrade
solo fruscii lontani oltre le dune
dall’erba rada e bassa
lenta nel crescere per ostinatezza del resistere
mentre lupi si azzannano
che più non riconoscono la stessa specie
nel bosco che sussulta
ingoia stelle come rimorsi
al largo
monta un fragore mediterraneo cupo
come di gorgo
si annega ancora sotto la nuova luna
in quel mare-di-mezzo che mediava
un tempo tra buio e luce
urti gentili
mi manca la lingua mi manca
quella timidezza di vocali aperte
di zeta dolce nel grazie
un incurvarsi della voce in gola
come a piegarla fossero le pietre
salentine del ricordo o forse
una malinconia residua della nascita
ingorgo che resiste
allo sperpero del vivere
furore dei cieli di una volta
grida bianche dei dolmen che insistono
nel vedere il mattino sorgere
sulle rovine ogni volta
qualunque sia l’inclinazione della luce
mi manca quella strana paura
prima di ogni viaggio
come un sottile rifiuto della distanza
come di albero che impone alle radici
un limite all’espandersi e si concentra
sulla cura dei frutti
pure amo
tutto questo calpestio di genti nella città
l’impasto lento di animelingue
il rompersi dei meridiani l’inarcarsi dei ponti per
urti gentili
questo annodarci annodando
i cesti della fiducia con antiche dita
dalla sezione Ciclica
revisioni
errore: non essere rimasti accanto al fuoco di fila
con occhi di cane a implorare o -- muso in alto -- ad abbaiare
urgenza del mutare
un grido-scheggia che trapassi la retina
apra varchi inattesi
un tempuscolo rovente che accenda
la permanenza stabile del coro
torre inattaccabile dove
le lingue si traducono solo sfiorandosi
così i fallimenti possono mutare
in categorie di seduzione
come la catena trasmessa dal seme al frutto
nonostante il marciume il trambusto dei rami
pagine ancora per voltare pagina
ancora
un sangue abbiamo consapevole
di voler coagulare come fosse troppo nobile
per l’uscita selvaggia dalla vena
umori fertili abbiamo
che premono sulla fioritura
e profili aggraziati a chiamare
la tenerezza degli urti le gratitudini
abbiamo sulla fronte un rogo che fa paura
ma nell’aggrottare appaiono onde
un oceano che trascina
il mio corrimano di legno tentativi di ponti
capre e pastori erranti (hanno il nostro profilo)
pani tastiere reti
incastrate tra rami di olivo e note di sassofono
e -- a ondate -- pagine
immarcescibili (la voce come di un’alba o di un vagito)
pagine ancora
per voltare pagina
è l’ora
raccogli i miei lumi residui
aprimi infine un po’del tuo segreto non
troverai fossette che ridono
solo indulgenza tremore trattenuto
inutile cercare la vertigine
resto inchiodata a un cielo calmo
da cui piovono miti anche feroci
ad es-empio se oggi
la bambina
(colei che vola sui sentieri)
nella coda al supermercato si sporge
dal carrello verso di me squillando
facciamo che io ero in macchina
e guidavo e volavo e tu dormivi
so
che sto andando verso la fine e lei
mi stringe forte la mano mentre
a me già la stanza si oscura