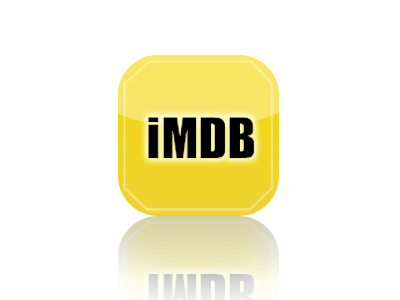Mario Benedetti, con Tersa morte (Mondadori 2013), mette in crisi l’implicito di ogni buon libro di poesia: quello sfondo che un corpo si porta dentro, nella forma della memoria luttuosa e della malattia, e che infetta la parola, ma non la annienta, anzi la fa splendere nell’ombra del lettore, rinvigorendone la promessa. Così era stato, in lui, sino a Umana gloria. Questo libro – radicalmente impoetico sotto questo profilo –sprofonda invece completamente nel nero, nella malattia e nel lutto, ma senza mai risalire, o raramente, spegnendo quella luce, che fa dire per esempio a Mario Luzi, rivolgendosi alla poesia: “Tu dammi il tralcio dei ritmi / il festone frondoso delle cadenze”. Dammi almeno il sorriso di Dioniso, se il senso ultimo delle cose è perduto.
A parlare, in Tersa morte, è invece una voce senza sostanza, “una voce qualunque” ridotta a nome, la quale ci ricorda, sottotono, che “non importa quello che si vede, non importa / quello che si dice o quello che si scrive”, perché nulla resta, nulla dura, se non la morte, che fa piazza pulita di ogni scoria. E tutto è scoria: case, città, epoche, ricordi, tranne gli affetti, ma che ora sono perduti, sprofondati nel nulla, inavvicinabili se non da un “sosia” che è memoria incarnata e inappartenente, “tempo portato addosso”, ugualmente infelice.
Niente sorride in questo libro, niente si salva, abbiamo detto; non tuttavia per mimetismo metodologico, secondo il quale se l’oggi è un tempo morto, se l’essenza dell’apertura storica, di cui siamo parola e gesto, è sprofondata nel nulla, se s’intomba nel più scuro non-senso, la poesia dovrebbe, per imitazione, smettere di cantare, essendo appunto il presente già estinto e vuoto. Se fosse questo il presupposto (lo fu nella Neoavanguardia) sarebbe l’esaurimento storico a chiedere l’esaurimento del discorso poetico, la sua afasia radicale. Un esaurimento del senso, dunque, ma non del soggetto che lo pronuncia, se non altro nella posizione di sopravvissuto, di colui che racconta la maceria, che la mette in atto da una posizione fondata, per quanto precaria. Con Tersa morte il presupposto cambia. Se in Umana gloria questo annientamento dello spazio-tempo terrestre era in parte tenuto lontano dalla pietà creaturale, adesso il risucchio annichilente messo in opera dalla morte è tale da ricondurre ogni essere, dentro e fuori dal libro, a ente inanimato o muto. Anche il lettore scompare, almeno nella sua funzione di soggetto interpretante. Ad esso spetta al più il compito di certificare l’avvenuto trapasso di ogni vivente dall’organico all’inorganico, “dal sangue, al sasso” direbbe Caproni, ma non ha appigli per rivendicare il diritto al disappunto, tanto è travolto dall’aurea mortifera che pervade ciascuna poesia. Il poeta stesso scompare, consapevolmente: “Sono questo, questa mortalità / che mi assedia, che si concentra / negli occhi, nelle mani. Intorno / sono mute le cose, le facce / che si muovono senza motivo, / e sento dissolvermi tra questo”.
La parola, dal canto suo, si arrende spesso all’indifferenziato, anche stilisticamente, attraverso una paratassi piana, che non è più solamente la cifra stilistica del poeta, come nei libri precedenti, ma inerzia di una voce che tenta di resistere all’annientamento. E questo capita perché l’unico soggetto, l’auctor fondante, qui, è la morte, tersa da ogni scoria; la morte e la sua solitudine infinita, la morte che parla a se stessa, in una circolarità desolata. Il suo essere soggetto ha infatti il modo dell’assoluto, del nient’altro-al-di-fuori-di-me. Il soggetto umano, invece, in quanto finito, si dà nel suo essere-relazione, nell’essere chiamato nell’aperto da un tu, che gli chiede ragione della sua opacità. Per questo motivo, la parola dei buoni libri di poesia cura i mortali dalla malattia dell’assoluto, aprendo al possibile, al non-ancora, all’imprendibilità del tutto terso o del tutto opaco. La morte a cui invece presta la voce Benedetti è, come appena rilevato, omnipervasiva e non ha parole da condividere con nessuno. Nemmeno con il poeta, assediato e convinto, dalla morte stessa, non solamente della propria inutilità, bensì della stessa possibilità autoriale, consegnandoci un libro che paradossalmente nessuno ha scritto: “Ma io nella mia vita non ho scritto nessuna poesia / […] / E questa nessuno l’ha scritta, nessuno l’ha letta”. Scompare la poesia, l’autore, il lettore. Rimane la morte, padrona del camposanto, al quale essa stessa ci ha invitati, ma per imbavagliarci. Bravo Benedetti quando riesce a prendere come un tempo la parola, a resistere alla tirannia della morte, rigenerando così lo spazio dei viventi, ripopolandolo: succede quando nomina le cose, le persone, i luoghi, colti in piccoli gesti quotidiani, in spazi ordinari, dove la natura e la civiltà, seppur martoriate, alzano ancora la testa e dialogano con noi, con i nostri lutti e le nostre memorie infrante. In queste occasioni, la radice friulana del poeta si sente e va benedetta.
Da Tersa morte (Mondadori 2013)
maggio 2010
Anni che non dovrebbero più, ore che non dovrebbero
prendermi i giorni, le settimane, i mesi. Il tempo
portato addosso, il sosia a cui chiedo di aiutarmi.
prendermi i giorni, le settimane, i mesi. Il tempo
portato addosso, il sosia a cui chiedo di aiutarmi.
Con la sedia di mio padre gioca la bambina che non conosco.
Adesso è sua. Gioca con quelli che diventeranno i suoi ricordi.
Adesso è sua. Gioca con quelli che diventeranno i suoi ricordi.
Tutto è una distanza sola. Le fermate sono da rimettere a posto.
Sollevare dei pesi, deporli. Lo sguardo s’inscurisce nella forma
di una porta marcita dove abita una signora anziana da sola.
Sollevare dei pesi, deporli. Lo sguardo s’inscurisce nella forma
di una porta marcita dove abita una signora anziana da sola.
Il sosia ascolta mia madre non morta, parla di mio fratello
o gli scrive. Pensa al protrarsi della vita che mi sopravvive.
o gli scrive. Pensa al protrarsi della vita che mi sopravvive.
*
Vado nell’aprile del duemila e dieci
quando la casa era nostra, e l’asfalto,
i fili della luce, le montagne, il sole.
quando la casa era nostra, e l’asfalto,
i fili della luce, le montagne, il sole.
Nessuno ci vedeva e noi vedevamo tutto.
Era il segreto di ognuno per vivere.
Era il segreto di ognuno per vivere.
Cade quella primavera sulle suole di neve
con il peso di tutti i miei anni:
un bianco pestato in un amaro sale grigio
la sola immagine, il mio corpo di adesso.
con il peso di tutti i miei anni:
un bianco pestato in un amaro sale grigio
la sola immagine, il mio corpo di adesso.
*
Il mio nome ha sbagliato a credere nella continuità
commossa, i suoi luoghi intimi antichi, la mia storia.
Le parole hanno fatto il loro corso.
Gli ospedali non hanno corsie. Dal cimitero dei cani
vicino alla discarica di Limbiate escono i morti al guinzaglio.
Non si addensa nulla, si disperde al telefono il mio petto.
Le parole hanno fatto il loro corso.
Sei solo stanco, ripete una voce qualunque.
commossa, i suoi luoghi intimi antichi, la mia storia.
Le parole hanno fatto il loro corso.
Gli ospedali non hanno corsie. Dal cimitero dei cani
vicino alla discarica di Limbiate escono i morti al guinzaglio.
Non si addensa nulla, si disperde al telefono il mio petto.
Le parole hanno fatto il loro corso.
Sei solo stanco, ripete una voce qualunque.
*
3 ottobre 2011
Le parole non sono per chi non c’è più.
Si commuovono e possono dire il viso morto.
Gli occhi erano quelli che mostrava,
il vestito sepolto quello visto altre volte.
Vedere che non ci sei più, non dire niente.
Si commuovono e possono dire il viso morto.
Gli occhi erano quelli che mostrava,
il vestito sepolto quello visto altre volte.
Vedere che non ci sei più, non dire niente.
*
Il sosia guarda, la vita ha deciso.
Vede gli ultimi giorni, si vergogna di scriverlo.
E’ avvolta nella coperta sui piedi,
il figlio senza lo stomaco mangia i pezzetti di trota
sulle scatole dello yogurt medicinale.
Giocato a carte nel bar del paese. Non visto il due.
Bevuto il caffè con la diarrea refrattaria.
E’ una storia per tutti questa morte.
Nella casa il sosia tocca le dita della madre
dicendole che il figlio è morto. Dopo la pleurite
un mese prima di compiere gli anni lei
ha detto: anch’io e la nostra casa non ci siamo più.
Vede gli ultimi giorni, si vergogna di scriverlo.
E’ avvolta nella coperta sui piedi,
il figlio senza lo stomaco mangia i pezzetti di trota
sulle scatole dello yogurt medicinale.
Giocato a carte nel bar del paese. Non visto il due.
Bevuto il caffè con la diarrea refrattaria.
E’ una storia per tutti questa morte.
Nella casa il sosia tocca le dita della madre
dicendole che il figlio è morto. Dopo la pleurite
un mese prima di compiere gli anni lei
ha detto: anch’io e la nostra casa non ci siamo più.
*
Il tram a Milano in viale Monte Nero,
eri seduta a guardarlo come guardavi i treni.
Con la bicicletta senza i freni,
dopo il passo di Monte Croce
per andare a Attimis, a Forame,
è stata una fortuna non cadere, sfracellarsi.
Sapevo che c’eri, che eri vicino a guardare
mentre io pensavo, e ti trattenevo.
Come una foglia tra le foglie
eri sulla panchina. C’erano alberi e alberi,
e il tuo viso, il vestito del solito blu.
Madre, persona morta
in viale Monte Nero, sulla strada per Attimis,
per Forame dove sei nata.
eri seduta a guardarlo come guardavi i treni.
Con la bicicletta senza i freni,
dopo il passo di Monte Croce
per andare a Attimis, a Forame,
è stata una fortuna non cadere, sfracellarsi.
Sapevo che c’eri, che eri vicino a guardare
mentre io pensavo, e ti trattenevo.
Come una foglia tra le foglie
eri sulla panchina. C’erano alberi e alberi,
e il tuo viso, il vestito del solito blu.
Madre, persona morta
in viale Monte Nero, sulla strada per Attimis,
per Forame dove sei nata.
Mario Benedetti è nato a Udine nel 1955 e vive a Milano.
Ha pubblicato le raccolte I secoli della Primavera (1992), Una terra che non sembra vera (1997), Il parco del Triglav (1999),Borgo con locanda (2000), Umana gloria (2004), Pitture nere su carta (2008), Materiali di un'identità (2010). Ha tradotto l'antologia poetica di Michel Deguy, Arresti frequenti (2007).
Ha pubblicato le raccolte I secoli della Primavera (1992), Una terra che non sembra vera (1997), Il parco del Triglav (1999),Borgo con locanda (2000), Umana gloria (2004), Pitture nere su carta (2008), Materiali di un'identità (2010). Ha tradotto l'antologia poetica di Michel Deguy, Arresti frequenti (2007).